
Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente). L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 30,4%, si ferma invece al 6,3% per le famiglie composte solamente da italiani. L’incidenza di povertà relativa familiare, pari al 10,6%, è stabile rispetto al 2022; si contano oltre 2,8 milioni di famiglie sotto la soglia. In lieve crescita l’incidenza di povertà relativa individuale che arriva al 14,5% dal 14,0% del 2022, coinvolgendo quasi 8,5 milioni di individui. Testo integrale e nota metodologica (.pdf, 566 Kb) Tavole (.xlsx, 103 Kb) fonte: ISTAT Periodo di riferimento: Anno 2023 Data pubblicazione: 17 Ottobre 2024
...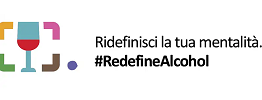
È partita il 2 ottobre la campagna-azione dell’Ufficio Regionale europeo dell’OMS “Redefine alcohol” volta a riconsiderare l’uso di alcol alla luce dell’evidenza scientifica dei benefici del non bere o del bere meno inteso come mezzo di prevenzione sulla rilevanza del rischio, anche oncologico, del consumo “moderato” insito anche in un singolo bicchiere. La campagna ha la durata di due mesi (si chiude il 30 novembre), al termine della Settimana europea di consapevolezza sui rischi causati dall’alcol (European Awareness Week on Alcohol Related Harm, AWAHR). L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) dell’ISS è partner formale di “Ridefinire l’alcol” e promuove per tutta la durata della campagna attività di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di contribuire a ridurre i rischi e i danni dell’alcol in Italia. Leggi l’approfondimento su EpiCentro con tutti i materiali divulgativi in italiano.
...
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Il testo non è al momento disponibile. Le anticipazioni fornite dal Governo sono ovviamente “rassicuranti” (comunicato stampa 100/2024) ma da quel che si può desumere dal Documento programmatico di bilancio DPB 2025 inviato all’UE (e dall’Appendice VI) vi sono solo impegni generici e le cifre (indicate solo per gli effetti in % sul PIL) riservate a sanità e a sociale appaiono per niente rassicuranti. Ciò è confermato da alcuni studi e commenti: UPB VALIDA PREVISIONI PIANO BILANCIO 2025-2029: ma segnala calo spesa sanitaria su PIL Manovra, Gimbe: ‘Salute è ormai un ministero senza portafoglio’ (ANSA) Anaao:“Il governo Meloni la smetta di prenderci in giro” Di seguito contenuti estratti dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2025 riferiti a Sanità e Non Autosufficienza SANITA’ Si sostiene la dinamica della spesa sanitaria che, come previsto nel PSBMT, crescerà a un tasso superiore a quello fissato per l’aggregato di spesa netta obiettivo, attraverso risorse in favore del personale e un incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale (pag. 6) Rafforzamento del sistema sanitario. Contenuto delle misure: Risorse a favore del personale sanitario e incremento del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale. e tabella II.1-13 pag. 17) NON AUTOSUFFICIENZA: … Rifinanziamento … del Fondo per le non autosufficienze. (pag. 6 e tabella II.1-13 pag. 17) Sono inoltre previsti interventi in materia di detassazione dei premi di produttività e per il welfare aziendale (pag. 7). Contenuti estratti dall’ Appendice VI al DPB 2025 “Sviluppo e riordino degli strumenti per la sanità integrativa, l’assistenza e la non autosufficienza, come il miglioramento della vigilanza dei fondi sanitare e le misure per l’assistenza a lungo termine” (Tavola A.VI.8 pag. 16) “Potenziamento dell’assistenza territoriale e edilizia sanitaria (ricorrendo anche a strumenti finanziari e al partneriato pubblico-privato).” (Tavola A.VI.8. pag. 17) “Aggiornamento dei LEA” (Tavola A.VI.8. pag. 17) Fonte: MEF
...
Sabato 26 ottobre 2024 giornata di mobilitazione nazionale a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bari, Palermo, Cagliari … FERMIAMO LE GUERRE Basta con l’impunità, la complicità, l’inazione Cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo Per una conferenza di pace ONU, per il rispetto e l’attuazione del diritto internazionale, dei diritti umani, del diritto dei popoli all’autodeterminazione, per il riconoscimento dello stato di Palestina, per risolvere le guerre con il diritto e la giustizia. Per la risoluzione nonviolenta delle guerre, per una politica estera italiana ed europea di pace, di cooperazione e di sicurezza comune Per il disarmo, per vivere in pace, per la giustizia sociale e climatica, per il lavoro, per i diritti e la democrazia Insieme per buttare fuori dalla storia tutte le guerre, le invasioni, le occupazioni, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, i genocidi, i terrorismi No al riarmo, no all’aumento delle spese militari, no alla produzione e diffusione delle armi nucleari no all’invio di armi ai paesi in guerra Per il diritto a manifestare, contro il ddl 1660 IL TEMPO DELLA PACE E’ ORA ADERISCI E COMPILA IL MODULO Giornata Mobilitazione 26 Ottobre 2024 fonte: https://www.perlapace.it/fermiamo-le-guerre-appello-citta-del-26-ottobre/
...
Da gennaio, oltre settanta detenuti e sette agenti della polizia penitenziaria si sono tolti la vita, senza contare che nelle prigioni italiane ci sono quattordicimila persone in più rispetto ai posti effettivamente disponibili. Dati su cui riflettere e un appello da sostenere. Non c’è più tempo: bisogna fermare la strage di vite e diritti nelle carceri italiane. Più di quanto non sia mai stato, le carceri italiane sono diventate un luogo di morte e disperazione. Dall’inizio dell’anno ormai ben oltre settanta le persone si sono tolte la vita dietro le sbarre, quanti non mai dall’inizio del secolo in poco più di nove mesi. E con loro hanno deciso di farla finita sette agenti di polizia penitenziaria. Ognuno di loro avrà avuto le proprie personali ragioni per arrivare a quella scelta ultima ed estrema, ma quelle morti ci interrogano sull’ambiente di vita e professionale in cui avvengono e sulle sue croniche carenze. Sono ormai 62.000 i detenuti nelle carceri italiane, circa quattordicimila in più dei posti effettivamente disponibili. In un anno, quasi quattromila in più. Si tratta in gran parte di autori di reati minori, condannati a pene che potrebbero dar luogo a un’alternativa al carcere se avessero un domicilio adeguato, una famiglia a sostenerli, un lavoro con cui mantenersi. Non più di un terzo è autore di gravi reati contro la persona o affiliato a organizzazioni criminali. È questo il contesto in cui si sta registrando un numero di suicidi senza precedenti, tra i detenuti e nella polizia penitenziaria. Il carcere, i suoi operatori, i detenuti non ce la fanno più. Anche i migliori propositi, come quelli condivisi dall’Amministrazione penitenziaria con il Cnel, di abbattere la recidiva attraverso il potenziamento della formazione, dell’orientamento e dell’inserimento lavorativo dei detenuti, per potersi avverare hanno bisogno di ridimensionare il numero dei detenuti in modo che gli operatori possano seguirli efficacemente. Per non dire della prevenzione del rischio suicidario e della necessaria assistenza sanitaria. È da molto tempo all’esame della Camera una apprezzabile proposta, avanzata dall’on. Giachetti, volta a potenziare le riduzioni di pena per i detenuti che partecipano attivamente all’offerta di attività rieducative proposte dal carcere. Ma, se vedesse finalmente la luce, non consentirebbe prima di qualche mese o addirittura di un anno l’uscita anticipata dal carcere di alcune migliaia di detenuti a fine pena, tanti quanti ne sono entrati nell’ultimo anno. Serve un intervento più deciso, che consenta la cancellazione drastica e immediata del sovraffollamento e la realizzazione delle condizioni per una più generale riforma del sistema penitenziario. E’ un intervento che la Costituzione prevede come strumento di politica del diritto penale quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, come certamente è questo il caso. Un provvedimento di clemenza generale, che potrebbe assumere le caratteristiche di una legge di amnistia e di indulto per i reati e i residui pena fino a due anni. In poche settimane, con l’indulto uscirebbero dal carcere circa sedicimila detenuti, con l’amnistia per i reati minori si alleggerirebbero i carichi di lavoro degli uffici giudiziari e per un po’ di tempo si eviterebbero nuove carcerazioni per reati minori. Tutti gli operatori della giustizia penale e del sistema penitenziario sanno che questa è l’unica soluzione disponibile ed immediatamente efficace per risolvere il problema del sovraffollamento. Il fatto che l’articolo 79 della Costituzione richieda una maggioranza speciale per l’approvazione di una legge di amnistia e di indulto, che pure meriterebbe di essere rivista, lungi dal costituire un impedimento assoluto alla sua approvazione, spinge a una condivisione di responsabilità tra le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per l’adozione di un provvedimento necessario a restituire condizioni di vita e di lavoro dignitose nelle nostre carceri. Condivisione che ci fu nel 2006, quando il presidente del consiglio Romano Prodi e il leader dell’opposizione Silvio Berlusconi si assunsero la comune responsabilità di votare a favore del più recente provvedimento di clemenza adottato in Italia, allora come oggi necessario al rispetto ai principi dell’articolo 27 della Costituzione. In ultimo, ricordiamo che – contrariamente a una errata opinione molto diffusa – quel provvedimento ha dato risultati molto positivi non solo nel decongestionamento degli istituti di pena, ma anche nella riduzione della recidiva: secondo la ricerca di Torrente, Sarzotti, Jocteau, commissionata dal ministero della Giustizia nel 2006, degli oltre 27 mila detenuti liberati grazie a quell’indulto, solo il 35% era rientrato in carcere cinque anni dopo, a fronte di un dato generale che vede intorno al 67% la percentuale di recidiva registrata tra quanti scontano interamente la propria pena in carcere; d’altro canto, secondo l’indagine di Drago, Galbiati e Vertova, pubblicata sul Journal of Political Economy, il tasso di recidiva tra i beneficiari dell’indulto del 2006 è diminuito del 25%. Dati su cui riflettere e da cui trarre coerenti conseguenze. Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Michele Ainis, Mons. Vincenzo Paglia, Gaia Tortora, Giovanni Fiandaca, Gherardo Colombo, Clemente Mastella, Daria Bignardi, Mauro Palma, Francesco Petrelli, Tullio Padovani, Rita Bernardini, Dacia Maraini, Alessandro Bergonzoni, Mattia Feltri, Andrea Pugiotto, Ornella Favero, Franco Corleone, Patrizio Gonnella, Franco Maisto, Luigi Pagano, Grazia Zuffa, Valentina Calderone, Samuele Ciambriello Per info e contatti: clemenzaperlecarceri@gmail.com fonte: Il Foglio (pdf)
...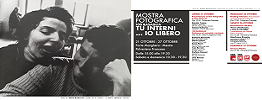
Per il centenario della nascita di Franco Basaglia, CGIL Venezia, SPI CGIL Venezia, FP CGIL Venezia e Festival dei Matti organizzano una mostra fotografica di Gian Butturini “Tu interni… io libero”. accompagnata da importanti iniziative. La mostra si terrà nella Polveriera Francese di Forte Marghera, e sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30, sabato 26/10 e domenica 27/10 dalle 10.30 alle 19.30. Presenteranno la mostra fotografica, alle ore 15.30 di lunedì 21 ottobre, Daniele Tronco, Segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia e Tiziano Butturini, fotografo e curatore della mostra. Seguirà l’iniziativa su “Psichiatria di comunità e Territorio”, alla quale interverranno Barbara Bonvento (Ricercatrice IRES Veneto), Mario Colucci (Psichiatra DSM Trieste), Anna Poma (Psicoterapeuta e ideatrice del Festival dei Matti), Ivan Bernini (Segretario generale FP CGIL Venezia), Stefano Cecconi (Segreteria SPI CGIL Nazionale). Coordinerà l’iniziativa Licia Barzan (Segreteria SPI CGIL Venezia). Mercoledì 23 ottobre, alle ore 17.00, Anna Toscano ci racconterà, attraverso un reading letterario, Goliarda Sapienza. Sabato 26 ottobre ore 10,30 Gianfranco Rizzetto (Associazione Festival dei Matti) e Daniela Codolo (Coordinatrice Donne Lega SPI Laguna Nord Est) converseranno con l’autrice Elena Cerkvenič del suo libro “Sono schizofrenica e amo la mia follia”. fonte: https://www.conferenzasalutementale.it/2024/10/11/centenario-basaglia-tu-interni-io-libero-21-27-settembre-mostra-e-dibattiti-a-forte-marghera/
...
Il governo prepara un’altra legge di bilancio che impoverisce il Paese. Non possiamo permettercelo. Per questo scenderemo in piazza in tutt’Italia. Diamo forza e potere a pensioni e salari! Mobilitazione dei pensionati e delle pensionate a contrasto di una legge di bilancio inadeguata ad affrontare le priorità delle persone e che per l’asse delle misure che si prospettano continua a promuovere un modello sociale da contrastare con fermezza. Lo SPI CGIL organizza mobilitazioni regionali nella settimana dal 28 al 31 ottobre che avranno al centro: tutela del potere d’acquisto dei pensionati; un sistema pensionistico che sappia garantire per gli attuali e per i futuri pensionati il giusto diritto alla pensione, risposte su sanità, non autosufficienza e fisco che garantiscano equità, universalità e redistribuzione a favore del lavoratori e dei pensionati oltre che delle giovani generazioni. fonte: https://www.cgil.it/campagne-e-iniziative/il-potere-dacquisto-logora-chi-non-ce-lha-mobilitazione-sindacato-pensionati-cgil-dal-28-al-31-ottobre-in-tutta-italia-n8h4qmce
...
In tante e in tanti abbiamo deciso di promuovere a Roma la II Conferenza nazionale autogestita per la Salute Mentale per concomitanti eventi e manifestazioni abbiamo dovuto spostare la data (prevista il 22 e 23 novembre) al 6 e 7 DICEMBRE 2024 SOTTOSCRIVI L’APPELLO che convoca la Conferenza e CONFERMA LA TUA PARTECIPAZIONE QUI in preparazione della Conferenza si è svolta un ASSEMBLEA sabato 21 settembre: VIDEO e si svolge un ASSEMBLEA il 24 ottobre a Carpi (e online: a breve le INFO) —> Al termine di un lungo percorso di assemblee partecipate abbiamo deciso di convocare la II Conferenza Nazionale nel centenario della nascita di Franco Basaglia, protagonista della “rivoluzione” nell’assistenza alle persone con disturbo mentale che ha portato alla legge di riforma del 1978. Con quell’atto di abolizione dei manicomi e di impostazione territoriale delle cure e dell’assistenza sono stati restituiti diritti e cittadinanza alle persone con sofferenza mentale, contrastando ogni forma di esclusione collegata a disabilità psico-sociale e si è spezzato l’infondato binomio malattia mentale/pericolosità sociale. —> Sappiamo bene che la riforma ha sofferto di una mancata applicazione uniforme nel paese, ma riconosciamo la forza e l’attualità del pensiero e dell’opera di Franco Basaglia e di quanti, tra operatori, familiari e cittadini, si sono spesi in tutti questi anni per creare processi liberatori ed emancipativi realizzando possibilità di cura nei luoghi di vita delle persone. —> Oggi viviamo però una drammatica situazione di arretramento. La debolezza culturale, organizzativa e di risorse dei Dipartimenti di Salute Mentale espone sempre più le persone con sofferenza, i loro familiari e la comunità tutta ad una condizione di abbandono, a prestazioni frammentate, per lo più farmacologiche, all’internamento in strutture residenziali istituzionalizzanti e cronicizzanti. Permangono, quando non crescono, stigma e pratiche non rispettose dei diritti fondamentali, la più estrema delle quali è la contenzione meccanica. Gravissima è la situazione nelle carceri e nel sistema di accoglienza per i migranti, in particolare nei Centri di Permanenza e Rimpatrio, dove la salute mentale delle persone ristrette e del personale sono costantemente messe a rischio. Mentre aumentano la povertà e l’insicurezza sociale, le operatrici e gli operatori del servizio pubblico, delle cooperative sociali, dell’organizzazioni del terzo settore operano in condizioni difficili, perfino di precarietà, che si riflettono sulla qualità della presa in carico e sulla qualità delle cure. Così anche le esperienze più qualificate e avanzate rischiano di arretrare. —> Questa situazione è ulteriormente compromessa dalla grave crisi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, indebolito da tagli e da spinte privatistiche, mentre si sfalda la rete dei Servizi Sociali nei territori. Neppure la tragedia della pandemia ha portato ad incrementare gli investimenti per la sanità pubblica e per il sociale, decisi nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza, e rilanciati con il PNRR. Pensavamo che fosse ovvio e scontato rendere strutturali quegli interventi, invece così non è stato, anzi. —> Di fronte a questa situazione, invece di potenziare e finanziare le tante opportunità offerte dalla legge 180, sperimentate con successo in molte realtà del nostro paese, vengono presentati in Parlamento disegni di legge che offrono ricette vecchie e fallimentari. È quello che abbiamo denunciato nel recente appello Fermare una tragica nostalgia di manicomio. E reagire. Di fronte a questa situazione il Governo, ma anche molte Regioni, sono inerti o intervengono con manovre che ci riportano indietro nel tempo e non vengono realmente incontro ai bisogni vecchi e nuovi dei cittadini di tutte le età. —> Di fronte a questa situazione vogliamo reagire: ecco perché convochiamo la II Conferenza nazionale autogestita per la Salute Mentale. La Conferenza vuole riproporrre uno stato di mobilitazione sociale PER sostenere rivendicazioni chiare, PER affermare il diritto alla tutela della salute mentale e alle cure, PER costruire alleanze e strategie di promozione dei diritti, PER riportare speranza e ricondurre all’ottimismo delle pratiche reali di emancipazione. La II Conferenza Nazionale autogestita si prefigge di: ➔ Valutare lo stato delle politiche e dei servizi, rilanciare il diritto alla tutela della salute mentale e alle cure che veda protagoniste le persone con esperienza e i familiari, proporre l’aggiornamento dei LEA e la formulazione di un Nuovo Piano Nazionale. ➔ Riorientare i Dipartimenti di Salute Mentale verso una cultura, un’organizzazione, una pratica di prossimità, radicata nel territorio, rispettosa delle norme internazionali sui diritti umani delle persone con disabilità, capace di garantire nella e con la comunità percorsi di presa in cura nell’ambiente di vita, anche durante le fasi critiche e di acuzie, attraverso progetti personalizzati finalizzati alla ripresa e all’emancipazione delle persone, prevenendo qualsiasi forma di istituzionalizzazione, con una specifica attenzione alle persone più a rischio di esclusione, ai bambini e ai giovani. ➔ Garantire ai Centri di Salute Mentale il ruolo di registi del sistema di cure in un territorio definito, con personale adeguato per numero, formazione, ruolo professionale. Servizi a bassa soglia, organizzati sulle 24 ore e con un’elevata capacità di promuovere integrazione sociale, sanitaria, lavorativa, abitativa. ➔ Abolire qualsiasi trattamento inumano e degradante, a partire dalla contenzione meccanica, e ogni forma di segregazione; ridurre i trattamenti senza consenso; garantire alle persone in cura l’esercizio dei diritti compreso le relazioni con le persone significative. ➔ Promuovere la partecipazione delle persone utenti dei servizi, dei familiari, delle associazioni che operano per la piena tutela della salute mentale e dei diritti umani, negli organi decisionali, favorendo la partecipazione attiva volontaria dei cittadini/e alle attività dei servizi, come insegnano tante esperienze nazionali e internazionali sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. ➔ Sviluppare nei servizi la qualità dei luoghi, delle relazioni, delle risposte insieme all’apertura costante alle comunità locali, come garanzia per la sicurezza degli operatori/trici e delle persone utenti. ➔ Stanziare un finanziamento adeguato per i Dipartimenti che assicuri il personale necessario e crei condizioni di lavoro rispettose dei bisogni e dei diritti di chi vi lavora e di chi usufruisce dei servizi offerti. ➔ Portare a termine la riforma che ha chiuso gli OPG con la L 81/2014, attraverso una legge che intervenga sulla non imputabilità per infermità mentale. ➔ Garantire il diritto alla tutela della salute mentale per le persone ristrette negli istituti penitenziari, favorendo programmi rieducativi, formativi e di inserimento al lavoro finalizzati alla costruzione di percorsi di inclusione sociale alternativi alla detenzione. ➔ Garantire la tutela della salute mentale per le persone ristrette senza aver commesso alcun reato nei Centri di Permanenza e Rimpatrio per i Migranti. ➔ Utilizzare gli strumenti esistenti della coprogrammazione e della cogestione per ridisegnare […]
...- SALARIO, SALUTE, DIRITTI, OCCUPAZIONE: Pubblico impiego, Cgil e Uil, la grande manifestazione a Roma

Il quadro che emerge dal Piano Strutturale di Bilancio ripropone le politiche di austerità che hanno già, in passato, indebolito il nostro sistema sociosanitario: tagli alla spesa pubblica, nessuna attenzione destinata al welfare, in particolare alla sanità pubblica, come inesistente è l’idea di investire sul personale che quotidianamente garantisce i beni e i servizi pubblici nel nostro Paese. Per queste ragioni, le categorie del pubblico impiego di Cgil e Uil, hanno ritenuto non rinviabile un segnale di forte contrarietà alle politiche che su questi settori sono state realizzate con lo scopo di rivendicare un cambio di passo proprio nella discussione della legge di bilancio. Sono scesi in piazza sabato 19 ottobre (rivedi la diretta) per rimettere in moto un sistema bloccato che fa fatica a garantire tutti i giorni diritti fondamentali, per qualificarne le prestazioni attraverso un adeguato riconoscimento salariale che non può rassegnarsi a certificare la perdita di dieci punti percentuali a causa dell’inflazione. Il rinnovo dei CCNL del settore pubblico è una delle vertenze cruciali nella più generale vertenza sui salari, che vedono il Governo non dare risposte adeguate. Risposte che non arrivano nemmeno dalle parti datoriali private. Il rilancio del Servizio sanitario nazionale non è più rinviabile: le condizioni in cui versano i pronto soccorso e gli operatori sanitari, la carenza dell’assistenza territoriale, il prolungamento delle liste d’attesa, le mancate risposte a non autosufficienza e disabilità, giorno dopo giorno, rappresentano una minaccia per milioni di cittadini che in molti casi hanno smesso di curarsi; rappresentano una delle basi del progressivo impoverimento di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati costretti a fare sempre maggiori sacrifici economici per affrontare la propria cura o quella dei propri cari. La crisi che stiamo attraversando e le rinnovate politiche di austerità toccano non solo la sanità, ma tutti i settori pubblici: quelli dello Stato come quelli del sistema delle autonomie locali, così come i settori della sicurezza e la sicurezza sul lavoro. La carenza di personale è ormai una regola e le condizioni di lavoro continuano a peggiorare esponendo parte del personale dei servizi pubblici a rischi e aggressioni. La precarietà è sempre più presente e condanna intere generazioni all’incertezza permanente. E sempre più cresce e si diffonde il progetto di privatizzazione di servizi essenziali. Per invertire questa condizione e rafforzare il sistema dei servizi pubblici CGIL e UIL rivendicano: un piano straordinario di assunzioni e l’incremento delle risorse destinate ai rinnovi dei CCNL 2022/2024 aumentare il finanziamento del SSN, sia in termini assoluti che in rapporto al PIL per abbattere le liste d’attesa rilanciare il ruolo e la funzione dell’assistenza territoriale, adeguando contestualmente la rete ospedaliera costruire e rafforzare le reti di sostegno alle persone anziane, a partire dalla garanzia di risorse per la non autosufficienza e dal miglioramento della normativa contrastare i processi di privatizzazione stabilizzare i precari A questi obiettivi non possiamo non collegare la nostra battaglia per il contrasto all’attuazione dell’autonomia differenziata che ci ha visti protagonisti nella raccolta firme per il referendum che ne chiederà l’abrogazione. Il diritto alla salute, a servizi pubblici efficaci, il diritto a salari dignitosi sono pilastri fondamentali della nostra società, diritti universali sanciti dalla nostra Costituzione che acquisiscono un valore ancor più crescente in un contesto socioeconomico complesso come quello attuale.
... 
Firenze – La dicitura di refertazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale, con particolare riferimento alla figura del fisioterapista, è al centro della proposta di risoluzione elaborata dalla Commissione Sanità, su cui il Consiglio regionale ha espresso voto favorevole all’unanimità. Ad illustrarla il presidente della commissione Sanità, Enrico Sostegni (Pd) che ha spiegato come l’atto sia seguito a un’audizione dell’Ordine dei Fisioterapisti della Toscana. “Nel decreto ministeriale del giugno 2023, definito Nuovo nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica – ha spiegato – sono contenute una serie di dizioni che generano un effetto perverso rispetto alle normative precedenti. In particolare la ‘dicitura di refertazione’ apre la strada a un’interpretazione per cui per accedere a qualsiasi prestazione fisioterapica sarebbe necessaria una prescrizione medica. Questo comporterebbe un arretramento della funzione e della professione dei fisioterapisti e creerebbe un effetto di imbuto e di blocco complessivo di tutto il sistema della riabilitazione. Con la risoluzione si chiede dunque alla Giunta di farsi carico in sede di Conferenza delle Regioni della richiesta di modifica di questa dicitura e di un chiarimento nell’ambito del nomenclatore tariffario i cui effetti non sono ancora evidenti poiché l’entrata in vigore del decreto è slittata al primo gennaio2025”. Nello specifico l’atto impegna la Giunta regionale “a promuovere, anche tramite la Conferenza delle Regioni, un confronto con il Ministero della Salute che assicuri il coinvolgimento delle Federazioni (FNOFI, FNOPI, FNO TSRM-PSTRP) e che, tenuto conto delle istanze di quest’ultime, possa giungere alla revisione dei LEA, oltreché all’istituzione del Nomenclatore delle Professioni Sanitarie”. La impegna anche “a istituire un tavolo di confronto e di lavoro in ambito regionale che veda la partecipazione dell’Ordine dei Fisioterapisti e dell’Ordine dei Medici, finalizzato ad assegnare alla figura del fisioterapista del Servizio sanitario regionale la facoltà di prescrivere ausili semplici per l’autonomia e indispensabili nei processi di continuità ospedale-territorio”. Nel testo dell’atto si ricordano le possibili ripercussioni negative sui servizi evidenziate dal Coordinamento regionale degli Ordini dei Fisioterapisti della Toscana (OFI) tra cui la riduzione dei livelli di appropriatezza; l’aumento dei tempi di attesa a danno dei cittadini in condizioni di cronicità e/o fragilità; la duplicazione di prestazioni e visite con aggravio dei costi per il servizio sanitario regionale; la perdita dell’autonomia dei fisioterapisti e del confronto diretto con i medici di Medicina Generale e gli altri specialisti di branca, con i quali i fisioterapisti hanno strutturato percorsi virtuosi. L’atto sottolinea inoltre come secondo l’OFI, “si renderebbe necessario prevedere delle modalità più snelle di presa in carico, anche attraverso l’accesso diretto al fisioterapista, da parte di utenti cronici e/o fragili che necessitano di interventi di consulenza e addestramento”. Istanze che la proposta di risoluzione chiede che vengano condivise dalla Giunta “con tutte le amministrazioni regionali in sede di Conferenza delle Regioni”. Andrea Ulmi (Gruppo Misto-Merito e Lealtà) ha affermato di condividere la preoccupazione che “si possa determinare un ingolfamento e un ulteriore orpello a carico dei medici che devono prescrivere le terapie”. “Un aggravio della burocrazia è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno – ha detto – E crediamo che questa proposta di risoluzione sia il giusto strumento per dare voce alle richieste degli operatori del settore che in commissione abbiamo audito”. fonte: articolo di Angela Feo su https://inconsiglio.it/comunicato-stampa/sanita-rivedere-i-criteri-del-nuovo-nomenclatore-tariffario-nazionale-per-i-fisioterapisti/ La lettera dell’Ordine dei Fisioterapisti Toscana ai parlamentari
...
